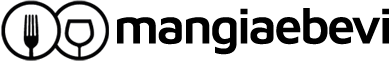Li a “Tra i Monti”, in Costiera Amalfitana, viti di pepella, ginestra, piedirosso e tintore sono sopravvissuti nel tempo, e oggi conquistano il naso e il palato di chi continua ad amare la semplicità del buon vino.
Continua il mio studio antropologico delle identità territoriali, alla ricerca del connubio perfetto tra viti e viticultori.
Poche settimane fa, i freni della mia auto si sono inchiodati a Tramonti, letteralmente “tra i monti”, nel bel mezzo di quelli Lattari, in Costiera Amalfitana. Qui, basta guardarsi intorno per capire che il concetto di “eroico” nella viticultura non è di certo un eufemismo.
In questa zona, i terrazzamenti sono lunghi pochi metri e larghi poco più di cinque, non c’è spazio per poter parlare di ettari: sono vigne dislocate da un lato ad un altro della vallata, in una serie di tornati scavati nei fianchi della montagna, dove al massimo si possono trovare quattro filari di viti su ogni gradone. Non ci sono neppure incertezze che una pianta e un uomo possano parlare all’unisono, che possano respirare la stessa aria, che possano vivere in totale simbiosi.
Le piante sono le viti di pepella, di ginestra e di Biancatenera a bacca bianca, sono le viti di piedirosso e di tintore a bacca nera. Sono le viti dell’Azienda Agricola Monte di Grazia, all’anagrafe Olivia e Fortunato prosecutori di Alfonso Arpino e sua moglie.

Qui la storia inizia negli anni 90, continua nel ’97 con la certificazione biologica e nel 2004 con il primo imbottigliamento. Prima di allora i nonni di Olivia e Fortunato si limitavano a produrre solo vino per la casa e a vendere la restante parte, forse per la poca cultura commerciale che ai tempi girava attorno al vino o forse ancor di più per le notevoli difficoltà di allevare le viti qui su, perché fare vino in questa zona non è di certo un “gioco da ragazzi”.
Spinta da questa storia affascinante, sono scesa dunque dall’auto e, infilando le galosche, ho iniziato a camminare tra terreni sciolti e friabili, formati da materiale piroclastico arrivati in Costiera dalle eruzioni del Vesuvio. Ad attendermi in vigna c’era già Olivia, la figlia di Alfonso.
Olivia è una ragazza bellissima, occhi intensi e profondi e mani piene di lavoro fatto e da fare ancora. Ci siamo presentate di fronte a una vite di tintore a piede franco, visto che in questa zona la filossera non ha mai avuto la meglio. Si tratta di una vite che potrebbe raccontare la storia di tre generazioni. Attorno a noi filari misti, dove il tintore si confonde alla biancatenera e al piedirosso, quest’ultimo un vitigno poco generoso sul piano produttivo, dall’alto livello zuccherino e da un’acidità, invece, abbastanza contenuta. Ecco perché molto spesso non è vinificato in purezza, ma in assemblaggio con altri vitigni.
Sopra le nostre teste una scultura di legni intrecciati che si allungano per interi metri a mo’ di tendone, that’is un allevamento a pergola! Sono tralci maestosi i cui busti vengono sostenuti da pali di castagno, mentre le loro radici scendono nell’entroterra fino a 30 – 40 metri ad incontrare la roccia vulcanica per trovare nutrimento. Questo vuol dire che, anche in annate di siccità come ad esempio è stata la 2017, le condizioni impervie le faranno un baffo.
Vedete in foto questi pezzi di legno? Si chiamano sarmenti. È lo scarto della potature, sono dei piccoli rametti che, anziché essere gettati, vengono utilizzati come esca per il tarlo del legno che, in estate, attacca la vite. Questo è saper custodire la cultura e l’intelligenza contadina!
Ma che significa certificazione biologica in questo paradiso di terra? Null’altro che la prosecuzione della tradizione agricola. Zappature o al massimo il sovescio per rinvigorire il terreno e rame, zolfo e letame per difendere la vite.
Il nostro giro tra le vigne si è concluso così, tra 5 diversi appezzamenti, in un labirinto di filari di tintore, di piedirosso, di ginestra, di pepella e di biancatenera, passando dai 200 metri sopra il livello del mare fino quasi ai 700, il tutto dislocato in un totale di appena 2 ettari e mezzo di vite ognuno distante dall’altro, e che solo grazie alla 4×4 di Olivia siamo riusciti a visitare.
La cantina

Poco più di 30 metri di spazio tra contenitori in acciaio e qualche piccola botte di castagno, frutto di esperimenti di Fortunato.
Le nuove annate confermano quanto sia faticoso quel lavoro in vigna e quanto poco lavoro interventista ci sia invece in questa sala.
Dopo la fermentazione, che parte spontaneamente, e senza temperature controllate, per i rossi, che macerano sulle bucce, Fortunato si dedica solo alle normali pratiche di cantina: follature a mano e rimontaggi, mentre i bianchi si fanno quasi da sé, lasciati, dopo i travasi, al loro naturale percorso fino all’imbottigliamento.
Qui abbiamo fatto diversi assaggi e mentre si parlava di vino, i discorsi sulle viti si intrecciavano a qualche spruzzo di conversazione personale, perché il vino è soprattutto quel mezzo o quel fine che ti apre alle conoscenze. Si diventa più umani con un calice in mano. E ci si dimentica delle sovrastrutture che affollano la mente.
Il pranzo e la degustazione
Fortunato aveva appena terminato alcune potature lì sulla collinetta di “Monte di Grazia”, uno dei cinque appezzamenti dove le viti vengono allevate e da cui prende il nome la stessa azienda, mentre la mamma era già intenta ai fornelli per quello che è stato un vero e proprio pranzo luculliano accompagnato da tutti i loro vini.
Siamo partiti dal loro base “Melogna”, un IGT rosso a base di piedirosso, tintore e una piccola percentuale sempre di autoctoni: moscio, olivella, e sciascinoso. Qui il mosto viene lasciate macerare sulle bucce per 4-5 giorni, poi la fermentazione alcolica continua senza buccia e riposa sulle fecce fini al suo primo travaso verso novembre.
Melogna, che in dialetto significa tasso, in onore a questi animali che vivono numerosi nel vigneto, è un vino facile, nell’eccezione buona del termine, così tanto facile da bere che non puoi distrarti, rischieresti di vedere il fondo senza saperlo. Questo grazie alla buona acidità data soprattutto dalla presenza del moscio, e dell’Olivella, mentre al tintore va soprattutto il merito di un coloro rosso vivido e brillante.
Questo vino non invecchia mai, e quella leggera carbonica che si avverte, in realtà, invoglia ad assaporarlo. Da bere leggermente fresco, questo il mio consiglio.
Ad accompagnare un piatto di spaghetti con le cime di rapa e alici, c’era un calice di Monte di Grazia Rosso, per me il loro vino d’eccezione.
Qui l’uvaggio è soprattutto di tintore con una piccola percentuale di piedirosso. Una macerazione pellicolare di circa 10 giorni, poi a riposare sulle fecce fini per qualche mese e una volta sfecciato continua ad affinare per ulteriori 36 mesi in acciaio (per alcune annate es. 2011,2012, 2013, 2018 c’è stato anche un breve passaggio di c.a 3 mesi in botti grandi di castagno).
Il mio calice era l’esatta rispondenza della sua annata, una 2014 molto piovosa, con una grandine che ha letteralmente dimezzato la produzione. Le acidità del vino durante l’imbottigliamento erano molto alte, ma con una gradazione alcolemica forse troppo bassa. Il tintore ha bisogno di tempo per esprimersi. Nel calice, c’era una buona acidità, profumo di prugne, spezie e frutti neri, una bocca rotonda e piena, che chiude verso sapori quasi ematici.
Ho un ricordo molto più piacevole di questa 2014, che della 2013, bevuta in passato. Questo a dimostrazione che annate, a volte definite un po’ “sfigate” sanno dare il meglio, se si sa attendere.
Da tre anni, nella famiglia è entrato una “nuova creatura”: lo Spurtiglione, un leggero macerato, di appena 5 giorni sulle bucce, di Ginestra, Biancatenera e un pizzico (20%) di Pepella.
Sono uve dal basso tenore zuccherino, soprattutto la ginestra, ma che di contro garantiscono una beva estremamente verticale, anche se la leggera macerazione favorisce una certa rotondità al palato.
Spurtiglione è l’incontro tra due mondi, la saggezza e l’innovazione: Alfonso il papà con le sue esperienze e suo figlio Fortunato con le sue sperimentazioni.
Alla fine in questo calice si è trovato il giusto punto di incontro, e il risultato è la contemperazione e la perfetta esaltazione del territorio senza quelle eccessive macerazioni che avrebbe potuto dissuadere e far perdere l’identità territoriale.
Lo Spurtiglione, in queste zone, è un pipistrello, quello che durante le ultime vendemmie ha fatto compagnia in Azienda alla famiglia e che pareva volesse vivere con loro.
Una produzione di appena 700 bottiglie, ai fortunati il privilegio di provarlo.
La mia visita in cantina è terminata poi con due annate del “Bianco” 2015 e 2016. La maestria di Alfonso ha raggiunto la massima esaltazione nell’annata 2015 che si presenta in splendida forma e pare anche più giovane della 2016, quest’ultima forse più ruffiana al palato.
Ginestra, Pepella e BiancaTenera, affinate solo in acciaio, sprigionano note agrumate e salmastre. La vicinanza al mare è fissata nelle pareti del calice. Un sorso salato e diretto. Note di macchia mediterranea, e sferzate minerali che garantiscono una bella verticalità al sorso. Non posso che convenire con Alfonso quando ci imbattiamo in un’equiparazione del suo bianco con la finezza di alcuni riesling alsaziani.
Il ricordo di quella visita all’Azienda Agricola Monte di Grazia, ha fatto nascere in me nuovi spunti di riflessione e nuovi punti di vista. Forse è questo il senso di un vero studio antropologico. La semplice conoscenza di un essere umano.